24 Apr Fake news: quali sono i rischi della disinformazione?
Le “fake news” possono essere definite come notizie false aventi una patina di verosimiglianza, basate su fatti inesistenti e messi in circolazione da fonti non attendibili, dalla cui diffusione si cerca di ricavare un qualche tipo di vantaggio o profitto; una notizia falsa diffusa online è, dunque, come un virus: si diffonde a un ritmo esponenziale e più persone contagia, maggiori sono i danni e più diventa difficile debellarla. Di fatti, molto spesso, queste circolano semplicemente per destabilizzare un ambiente, aggirare i controlli della stampa, prendersi gioco di determinati gruppi sociali.
Vi sono vari tipi di creatori di notizie disinformanti. La prima categoria riguarda i siti web che vivono del fenomeno del cosiddetto “click baiting”: si pubblicano notizie false con foto e titoli sensazionalistici per attirare clic sulle proprie pagine e guadagnare con le impressioni degli annunci online. Oltre alle false informazioni, questi siti sono pericolosi perché spesso contengono malware o altre simili minacce informatiche. Sebbene tali malware non possano danneggiare gli hardware fisici di un sistema o le attrezzature di rete, possono rubare, criptare o eliminare dati, alterare o compromettere le funzioni fondamentali di un computer, spiare le attività degli utenti senza che questi se ne accorgano o forniscano alcuna autorizzazione.
La seconda categoria di autori di bufale online è costituita da attori sociali che utilizzano le fake news per manipolare l’opinione pubblica, ad esempio per screditare un determinato personaggio di nota visibilità, creare consenso intorno a temi sensibili o addirittura influenzare circa eventuali scelte.
Infine, come terza categoria di autori di fake news, ci siamo noi, gli utenti di internet a cui piace condividere notizie e contenuti sui social media, convertendoci senza saperlo in un’enorme cassa di risonanza per le disinformazioni. Sui social, le notizie false, come quelle vere, si diffondono a macchia d’olio per vari motivi: da un lato, sono i mezzi stessi a permetterci di condividere le notizie con un semplice clic; dall’altro, vi sono alcuni meccanismi psicologici per cui lo facciamo senza verificarle, tra cui il più importante è probabilmente il pregiudizio di conferma: ovvero la tendenza ad accettare e condividere le informazioni che supportano le nostre credenze e respingere quelle contrarie. Di conseguenza, il rischio maggiore che corriamo è radicalizzare sempre di più le nostre opinioni, lasciandoci manipolare invece di agire in modo razionale e libero.
Nella fattispecie in esame, tre sono le circostanze di reato che ci interessano, le quali sono previste in apertura del Libro Terzo del Codice Penale, tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica: si tratta delle ipotesi previste dall’art. 656 c.p. in materia di pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, che sanziona, con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino ad € 309, chi pubblichi o diffonda una notizia falsa, esagerata o tendenziosa idonea a turbare l’ordine pubblico; dall’art. 658 c.p. in materia di procurato allarme presso l’Autorità, che punisce, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 10 a € 516, chi, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, susciti allarme presso Autorità o esercenti di pubblico servizio; dall’art. 661 c.p. in materia di abuso della credulità popolare, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000, per chiunque pubblicamente cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, ove dal predetto fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico.

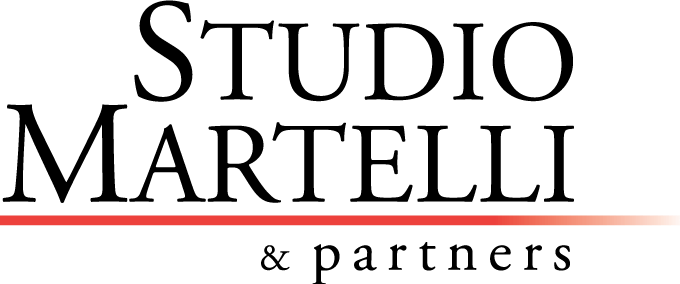

Sorry, the comment form is closed at this time.