13 Lug Il problema del profilo di responsabilità nell’era 5G
L’avvento del 5G ha catapultato l’intera umanità in una realtà virtuale interconnessa fatta di telefoni, case, auto, uffici in grado di dialogare tra di loro grazie a un satellite che ha il potere di trasformare in atto la volontà dell’uomo, senza un vero intervento fisico da parte sua.
Una rivoluzione che sta investendo molti aspetti della nostra vita e da cui il mondo delle assicurazioni non resta al riparo. Correva l’anno 1969 (Legge 24.12.1969 m. 990, integrata dal d.lgs. 7.9.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private) quando la prima “assicurazione obbligatoria” fece il suo ingresso nell’ordinamento italiano.
Da allora sono passati 50 anni, la maggiore parte dei quali non ha vissuto grossi cambiamenti ad eccezione degli ultimi, in cui il mondo assicurativo è stato travolto come un tornado dai nuovi sistemi IoT e dalle applicazioni di IA.
Si prevede che per il 2020 sarà commercializzata la prima auto intelligente in grado di guidare da sola.
Una vera rivoluzione copernicana che vede il conducente trasformarsi in passeggero, il soggetto in oggetto, l’auto, da strumento passivo, a macchina decisionale.
L’Internet of Things e l’Intelligenza Artificiale entrano prepotentemente nel settore assicurativo che sarà costretto a modificare il proprio punto di vista per adattarlo al nuovo mondo che verrà. Molti sono gli aspetti che dovranno essere messi in discussione, in primis , il profilo di responsabilità.
La fattispecie della RC-Auto copre quei danni che il mezzo può causare a terzi (persone, cose ed animali); con la stipula della polizza, in pratica, a fronte del pagamento di un premio assicurativo, il contraente trasferisce sulla compagnia assicurativa l’onere di pagare gli aventi diritto nel caso di un sinistro di cui egli abbia colpa.
Trattasi di una forma di responsabilità civile, extra contrattuale o aquiliana ex art. 2043 cod. civ. (derivata dalla Lex Aquilia del 287 a.C. che, per prima disciplinò, nel diritto la responsabilità ex delicto), però con caratteristiche peculiari, individuate dall’art. 2054 cod. civ. secondo il quale, da un lato, il conducente è responsabile dei danni a persone e a cose se non prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare” i danni medesimi e, dall’altro, il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) è responsabile in solido con il conducente se non prova “che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
La peculiarità della norma richiamata consiste nel fatto che l’evidente difficoltà per il conducente e per il proprietario di fornire siffatta prova liberatoria fa sì che, di fatto, essi non possano ordinariamente evitare le conseguenze della loro presunta responsabilità.
In ogni caso, la polizza RC-Auto, a differenza di una qualsiasi assicurazione contro i danni, opera solo laddove sia presente nell’assicurato l’elemento soggettivo della colpa e non vi sia contestualmente alcuna traccia di responsabilità da parte del soggetto leso con l’ulteriore garanzia per quest’ultimo che, il legislatore ha escluso la facoltà in capo alla compagnia di assicurazione di opporre al danneggiato le eccezioni opponibili nei confronti dell’assicurato.
Oggetto dell’assicurazione obbligatoria è, infatti, la responsabilità sicché non si è tutelato l’interesse di coloro che sono esposti al rischio della strada tutte le volte che il danno è imputabile allo stesso danneggiato.
Qualora si fosse, invece, ritenuto di dover proteggere il danneggiato, in questi ultimi casi, lo strumento idoneo non sarebbe stato l’assicurazione della responsabilità, bensì l’assicurazione diretta del danno alla persona e delle cose, come è accaduto da tempo per la copertura del rischio degli infortuni sul lavoro.
La responsabilità civile grava sul proprietario e sul conducente del veicolo responsabile a differenza della responsabilità penale che grava unicamente sul conducente, nelle ipotesi in cui il sinistro stradale provoca lesioni gravi a persone, in caso di omicidio (anche colposo) ecc.
Il meccanismo della responsabilità ancorata all’elemento soggettivo non viene meno neppure con l’introduzione della procedura di indennizzo diretto in quanto, il danneggiato richiede il risarcimento direttamente alla propria assicurazione, che anticipa solo l’importo concordato facendoselo poi rimborsare dall’assicurazione della controparte – responsabile. Seppur sussistono forme di attenuazione, basti pensare alla tutela risarcitoria riconosciuta al soggetto trasportato.
Premesso il meccanismo di responsabilità (colposa e, addirittura, dolosa – C. Cass. 20.08.2018 n. 20786) che governa il rapporto tra assicurazione (e per essa l’assicurato) ed il danneggiato, ci si chiede come possa adattarsi tale fattispecie alla messa in circolazione delle auto intelligenti in grado, cioè, di guidare da sole (o quasi!).
Si convergerà sempre di più verso forme di responsabilità oggettiva, ovvero forme di responsabilità che prescindano dall’elemento soggettivo (dolo o colpa)? E in merito alla responsabilità penale, per sua natura personale (art. 27 della Costituzione), si invertirà la, pur lenta e farraginosa, tendenza all’eliminazione (dapprima, attraverso l’elaborazione delle teorie sulla colpevolezza e, poi, attraverso progetti di riforma del Codice mai “andati in porto”) di fattispecie di responsabilità oggettiva di cui risente il Codice Rocco (del 1930), creatura dell’età Fascista?
Crediamo che la risposta sia affermativa, molto dipenderà dal grado di autonomia delle autovetture intelligenti di procedere alla guida senza interazioni e/o interferenze del conducente che diventerà “trasportato” dalla IA? Ci si interroga anche sulla portata che potrà assumere l’obbligo a contrarre per la compagnia di assicurazione.
Allo stato, infatti, in virtù dell’obbligo dell’assicurazione per responsabilità civile (Legge 24.12.1969 m. 990) sussiste un obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazioni che possono prevedere un premio tariffario adeguato al rischio che si vedono costrette ad assumere e limitare le coperture con la previsione dei massimali che, in ogni caso, non possono essere inferiori a quelli introdotti dalla legge.
Sul punto si è pronunciata più volte la Corte di Giustizia Europea, chiamata dalla Commissione Europea, in merito all’obbligo a contrarre.
La Corte (alla luce della Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che, regolamenta la disciplina relativa alla copertura assicurativa per la responsabilità civile) non ha ravvisato alcuna restrizione alla libera circolazione delle imprese laddove la limitazione non è volta ad impedire l’insediamento delle imprese di altri stati membri nel territorio italiano.
L’obbligo a contrarre lascia impregiudicato per le imprese il diritto di accesso al mercato italiano dell’assicurazione nel ramo della responsabilità civile auto. Tuttavia in Italia, si ritorna, al delicato e peculiare problema della complessa situazione nazionale, dove il consistente tasso di sinistri stradali verificatisi in alcune parti del territorio comporta notevoli esborsi per le compagnie di assicurazione, che si sono viste costrette a ridistribuirli sull’intero portafoglio clienti.
Le compagnie assicurative italiane, infatti, non potendo rifiutare la copertura assicurativa a clienti con alto tasso di sinistrosità, sarebbero costrette a proporre premi tariffari che buona parte di questi non sarebbero in grado di pagare. Ecco che, per garantire l’osservanza al dettato normativo, il costo del rischio assicurativo viene parzialmente caricato su tutti i clienti dell’impresa di assicurazione.
Pertanto, l’alternativa vivamente caldeggiata dalle società di assicurazione di destinare quella parte di mercato altamente rischiosa ad imprese specializzate appare difficilmente realizzabile in Italia. E con l’introduzione di una forma di responsabilità civile oggettiva?
L’obbligo a contrarre per le compagnie assicurative lascerebbe comunque impregiudicato il principio cardine dell’Unione Europea, della libera circolazione delle imprese?
Quale potrebbe essere il criterio adottabile dalle compagnia assicurative (oggi bonus/malus ed attestato di rischio parametrato sulla responsabilità dell’assicurando nella causazione dei sinistri pregressi) per commisurare all’assicurando un premio tariffario adeguato al rischio che si vedono costrette ad assumere, venuto meno il criterio della responsabilità nella causazione dei sinistri?
Molti e significativi sono i quesiti che il “progresso” ci prospetta all’orizzonte! Non per ultimo ci si chiede quale sarà il ruolo del legale in questo nuovo scenario. Certamente si fa strada l’esigenza di un profilo legale di altissimo livello capace di confrontarsi con nuovi parametri giuridici e in grado di dialogare con la realtà IoT.

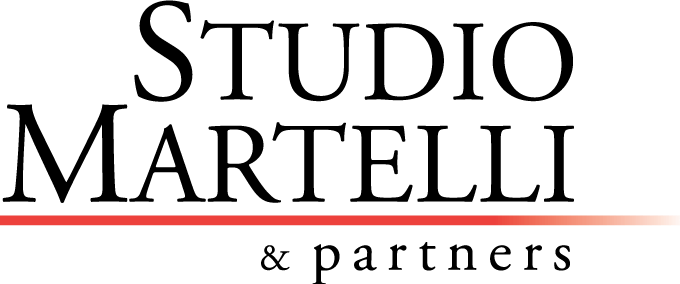

Sorry, the comment form is closed at this time.